Francesco
Neri
DON TONINO BELLO:
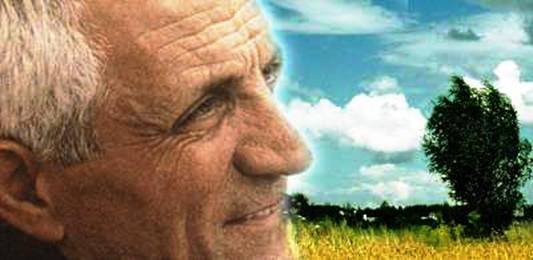
Il vescovo Antonio Bello, o –
come egli stesso incoraggiava a chiamarlo – «don Tonino», ha speso la sua
esistenza nell’arco breve di cinquantotto anni, gli ultimi dieci dei quali sono
stati impegnati nel ministero episcopale. Le scansioni biografiche essenziali
possono essere così individuate[1].
Egli nasce ad Alessano, il 18
marzo 1935, piccolo centro a pochi chilometri dal Capo di Leuca[2].
Dopo la scuola elementare, nel 1946 entra nel seminario diocesano di Ugento, e
vi frequenta la scuola media. Nel 1949 si trasferisce nel seminario regionale
di Molfetta, sino alla maturità classica, conseguita nel 1953. In quest’anno,
intraprende gli studi di teologia nella Bologna del cardinal Lercaro, presso il
seminario dell’O.N.A.R.M.O. Contemporaneamente attende alla licenza in
teologia, che consegue nel 1957 presso la Facoltà Teologica
di Venegono. Appena ventiduenne, l’8 dicembre 1957 viene ordinato sacerdote
nella chiesa madre di Alessano, da mons. Giuseppe Ruotolo, vescovo di Ugento e
S. Maria di Leuca. Nel 1958 inizia un lungo periodo di ministero nel seminario
di Ugento, dove rimarrà sino al 1977, svolgendovi i compiti di docente, vice
rettore e, dal 1974, rettore. Nello stesso arco di tempo, il 1° gennaio 1962
emette la professione nel Terz’Ordine Francescano, e, sempre dal 1962, entra
nell’esperienza del Concilio Vaticano II, in qualità di consulente teologico
del vescovo Ruotolo. Il 1965 è l’anno del conseguimento del dottorato in teologia,
presso l’Università del Laterano, con una tesi in tema eucaristico[3].
Dal 1970 al 1975 è assistente diocesano dell’Azione Cattolica. Dal 1975 al 1978
è direttore dell’Ufficio pastorale diocesano. Il nuovo vescovo di Ugento, mons.
Michele Mincuzzi, gli affida la parrocchia della Natività di Maria a Tricase,
in cui don Tonino fa ingresso il 14 gennaio 1979. Nel 1981 muore la mamma,
Maria. Antonio Bello, che già due volte aveva rifiutato la nomina episcopale
per via dell’avanzata età della madre, ormai non ha più motivi per sottrarsi
all’incarico. Il 10 agosto 1982 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo della
diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, e il 30 settembre anche di quella di
Ruvo, accorpata alla precedente. Nella piazza principale di Tricase, il 30
ottobre 1982, a
quarantasette anni, viene ordinato vescovo da mons. Mincuzzi, nel frattempo
divenuto metropolita di Lecce. Il 21 novembre fa ingresso nella diocesi di
Molfetta.
La nuova stagione della vita di
Antonio Bello reca impresso il segno della sua personalità ricca ed evangelica.
Visita gli emigrati della sua diocesi residenti all’estero: Australia (1983),
Argentina (1985), USA (1986), Venezuela (1988). Apre le porte dell’episcopio
agli sfrattati. Organizza una casa di accoglienza per stranieri, una struttura
di recupero per tossicodipendenti, un centro per l’assistenza agli accattoni e
ai senza tetto. Si schiera a difesa dei cittadini e dei lavoratori in
problematiche urbanistiche e occupazionali. Offre un ritiro annuale agli uomini
politici delle sue città. Nel 1990 vola in Etiopia e per la prima volta tocca
con mano il problema della povertà nel Sud del mondo. Nello stesso anno si reca
in Salvador per il decimo anniversario della morte del vescovo Oscar Romero. Il
suo ministero episcopale a tutto campo è documentato dai progetti pastorali[4].
Il 3 novembre 1985 la Conferenza Episcopale
Nello stesso 1991 si profila
una nuova sfida, di genere affatto diverso. Nell’estate gli viene diagnosticata
una grave forma di tumore, per la quale subisce un primo intervento
nell’ospedale di Gagliano del Capo. Non permette alla malattia di fermarlo nel
suo impegno pastorale, ma nel 1992, ad agosto, avverte i sintomi del risveglio
della patologia. A dicembre, dal 7 al 13, guida la missione dei Trecento che,
in piena guerra di Bosnia, portano l’annuncio di pace a Sarajevo. Nel 1993, il
12 febbraio, a causa dell’improvviso aggravamento delle sue condizioni, gli
viene amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi. L’8 aprile 1993
Antonio Bello è presente alla Messa crismale, nella cattedrale di Molfetta.
Siede su una poltrona, ormai segnato dalla malattia, ma è rivestito delle
insegne episcopali. Al termine della celebrazione eucaristica, prende la parola
per l’ultima volta in pubblico in modo ufficiale. Augura a tutti la speranza e
la fioritura primaverile. Augura a tutti la pace della sera, quella che chiude
la giornata della quotidiana e la giornata della vita. Invita ad amare Gesù
Cristo e i poveri. Muore pochi giorni dopo, alle ore 15.26 del 20 aprile 1993,
nell’episcopio di Molfetta.
Per conoscere l’anima di
Antonio Bello e le radici delle sue iniziative pastorali, così di quelle
clamorose come di quelle quotidiane e nascoste, il primo strumento è la
raccolta dei suoi Scritti.
Organizzata su un piano di sei volumi[5],
finora essa comprende (1) Diari e Scritti pastorali, (2) Omelie e Scritti quaresimali, (3) Scritti
mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali e Preghiere, (4) Scritti di
pace, (5) Articoli, Corrispondenze, Lettere e Notificazioni.
Occorre sottolineare
l’originalità del linguaggio usato da
don Tonino. Egli è stato un sapiente comunicatore, capace di coniugare parole
brillanti, immagini efficaci e silenzi espressivi. Alle radici vi è la lunga
frequentazione del mondo della cultura extrateologica, risalente in modo
particolare agli anni del seminario di Ugento. Numerosissime compaiono citate
nei suoi testi opere note e meno note di letteratura, cinema, musica e pittura.
Ma oltre alla parola orale e alla parola scritta[6],
Antonio Bello ha saputo usare il linguaggio dei simboli: la vecchia Cinquecento con cui circolava, la fisarmonica
che imbracciava nei momenti di festa, le rielaborazioni creative e fedeli delle
liturgie, e così via. Studiati o spontanei, tali simboli trasmettevano
indelebilmente l’anima di don Tonino. Essenziale caratteristica del suo
linguaggio è stata, infine, l’affettività.
Proprio su questo registro si articolano le parole pronunciate durante la messa
crismale del 1993, l’ultima celebrata in pubblico prima della morte: «Vorrei
dire a tutti, ad uno ad uno, guardandolo negli occhi: “Ti voglio bene”, così
come, non potendo adesso stringere la mano a ciascuno, però venendo vicino a
voi così personalmente, vorrei dire: “Ti voglio bene!”»[7].
La teologia e la prassi di pace
di don Tonino scaturiscono anzitutto alla sua fede, dal suo cristocentrismo
trinitario, e si sondano lungo i tre sentieri del servizio, dell’accoglienza e
del dialogo.
La centralità del Signore Gesù
Cristo
Dinanzi ai molti tentativi di
appropriazioni e strumentalizzazione della persona e dell’opera del vescovo
Antonio Bello, dinanzi alle troppe interpretazioni unilaterali e riduttive,
l’affermazione fondamentale su questo testimone della Chiesa contemporanea deve
essere che don Tonino Bello è stato un
cristiano, radicalmente e profondamente. Tutte le iniziative del suo
ministero, anche quelle più sconcertanti, sono comprensibili solo come il
desiderio di aderire a Cristo e di mettere in pratica il Vangelo senza riserve.
Al cuore della sua
testimonianza vi è dunque la centralità
di Cristo. Ai sacerdoti ai quali predica gli esercizi spirituali, egli
trasmette l’entusiasmante appello ad una scelta radicale: «Innamorarsi di Gesù
Cristo, come fa chi ama perdutamente una persona e imposta tutto il suo impegno
umano e professionale su di lei, attorno a lei raccorda le scelte della sua
vita, rettifica i progetti, coltiva gli interessi, adatta i gusti, corregge i
difetti, modifica il suo carattere, sempre in funzione della sintonia con lei.
[…] Quando parlo di innamoramento di Gesù Cristo voglio dire questo: un investimento
totale della nostra vita. […] Innamorarsi di Gesù Cristo vuol dire: conoscenza
profonda di lui, dimestichezza con lui, frequenza diuturna nella sua casa,
assimilazione del suo pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze più radicali
e più coinvolgenti del Vangelo. Vuol dire ricentrare davvero la nostra vita
intorno al Signore Gesù»[8].
La centralità di Cristo è comunque l’opzione per tutti i cristiani: «Se voi vi
innamoraste di Gesù, – scrive alla sua diocesi nel giorno di san Valentino –
così come nella vita vi siete innamorati di una povera creatura, o di una povera
idea… il mondo cambierebbe»[9].
Il dato da cui parte
l’innamoramento è l’umanità di Gesù. Questa Antonio Bello addita ai
sacerdoti come archetipo di spiritualità e criterio di santità: «Caro cardo
salutis: la carne è il cardine della salvezza. La carne, il corpo, la visibilità
sono il cardine attorno a cui si articola la salvezza, anzi sono la feritoia attraverso
cui l’opera salvifica di Dio entra nelle arterie della storia. Se è così, dobbiamo
esprimere anche visibilmente il nostro amore per Gesù Cristo, il nostro amore
per il Vangelo, il nostro amore per il mondo, per la terra, per cui siamo costituiti
sacerdoti. Dobbiamo esprimerlo anche attraverso le vibrazioni del nostro
essere, del nostro corpo. La gente deve capire che dalle nostre mani si spande
il buon profumo di Cristo, la gente deve intuirlo questo, deve capire che noi
abbiamo messo gli occhi negli occhi di Dio, che lo abbiamo toccato il Signore,
che gli siamo stati vicini»[10].
Antonio Bello vede l’umanità di
Cristo risplendere soprattutto nei misteri dell’Incarnazione e della Croce.
Commentando Isaia 53,4, che descrive l’espiazione vicaria del Servo di JHWH
(«Si è caricato delle nostre sofferenze, e si è addossato i nostri dolori»), il
vescovo di Molfetta afferma che questa frase lo fa rabbrividire, soprattutto a
Natale e a Pasqua: «A Natale, quando contemplo Gesù condannato al legno della
mangiatoia. A Pasqua, quando mi inginocchio davanti a Gesù condannato al legno
della croce. Mangiatoia e croce (i due assi che comprimono tutta l’esistenza
umana del Figlio di Dio) mi sembrano allora legni così porosi, che riescono a
prosciugare, come spugne gigantesche, tutte le tristezze del mondo»[11].
Antonio Bello ha però del
Mistero pasquale una visione completa, fortemente attenta alla Risurrezione e al rovesciamento totale
che tale avvenimento di salvezza introduce nella storia umana. Proprio
all’annuncio del Cristo Risorto, Antonio Bello dedica le sue ultime parole,
durante la messa crismale del 1993, chiudendo la celebrazione con un discorso
spontaneo, che tradisce l’intimo del suo spirito: «Io ho voluto prendere la
parola per dirvi che non bisogna avere le lacrime, perché la Pasqua è la Pasqua della speranza,
della luce, della gioia, e dobbiamo sentirle. Io le sento veramente, perché il
Signore è risorto, perché Egli è al di sopra di tutte le nostre malattie, le
nostre sofferenze, le nostre povertà. È al di sopra della morte. Quindi,
ditelo!»[12].
È allora giusto affermare che il Calvario è solo «un parcheggio» e che la Croce è su quel monte in
«collocazione provvisoria»: «Nel Duomo vecchio di Molfetta c’è un grande Crocifisso di terracotta. L’ha donato, qualche hanno fa, uno scultore del
luogo. Il parroco, in attesa di
sistemarlo definitivamente, l’ha addossato alla parete della sagrestia, e vi ha
apposto un cartoncino con la scritta: collocazione
provvisoria. La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell’opera,
mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il
parroco di non rimuovere per nessuna ragione il Crocifisso di lì, da quella
parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito.
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la Croce. La mia, la tua
Croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora!»[13].
La
unità nella trinità di Dio come archetipo delle relazioni e tavola promessa
Oltre alla dimensione pasquale,
il cristocentrismo di Antonio Bello è segnato da una costante prospettiva trinitaria. Nel mistero
della Trinità di Dio, egli radica i progetti pastorali per la sua Chiesa
diocesana così come le iniziative a vantaggio dei poveri e della pace. Lo
descrive attraverso la spiegazione offertagli da un suo amico prete impegnato
tra gli zingari: «Io ai miei zingari sai come spiego il mistero di un solo Dio
in tre Persone? Non parlo di uno più uno più: perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre
uno. […] In Dio ogni Persona vive per l’altra.
E sai come concludo? Dicendo che questo è una specie di marchio di famiglia.
Una forma di “carattere ereditario” così dominante in “casa Trinità” che,
quando è sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come l’uomo per gli altri»[14].
Proprio nel mistero trinitario
don Tonino radica il modello delle relazioni e la meta che ci attende
nell’eternità. Egli scrive che «quella trinitaria non è solo una dottrina da
contemplare, ma un’etica da vivere. Non solo una verità tesa ad alimentare il
bisogno di trascendenza, ma una fonte normativa cui attingere per le nostre
scelte quotidiane. […] Nel cielo tre Persone uguali e distinte vivono così
profondamente la comunione che formano un solo Dio. Sulla terra più persone,
uguali per dignità e distinte per estraniazione, sono chiamate a vivere così
intensamente la solidarietà, da formare un solo uomo, l’uomo nuovo: Cristo
Gesù. Sicché l’essenza della nostra vita etica consiste nel tradurre con gesti
feriali la contemplazione festiva del mistero trinitario, scoprendo in tutti
gli esseri umani la dignità della persona, riconoscendo la loro fondamentale
uguaglianza, rispettando i tratti caratteristici della loro distinzione. […]
Questa, in ultima analisi, è la pace: la convivialità delle differenza.
Definizione più bella non possiamo dare. […] Ma c’è di più: […] la Trinità non è solo un
archetipo da riprodurre, ma è una tavola promessa alla quale un giorno avremo
la sorte di sederci, all’unica condizione che anche sulla terra ci si alleni a
stare insieme con gli altri alla stessa mensa della vita»[15].
Il grembiule di Cristo e della Chiesa
Questa è certamente l’immagine
per la quale don Tonino è più noto e che gli viene indissolubilmente associata:
la chiesa del grembiule. Nella sua
esegesi della lavanda dei piedi (Giovanni 13,1-20), Antonio Bello
trasferisce alla Chiesa il gesto con cui il Signore ha deposto le vesti ed è
passato a servire i suoi apostoli. Chi riceve da Cristo deve però
ritrasmetterlo, alzandosi da tavola e passando a servire. Cingendo il
grembiule, appunto.
«Chi si alza
dalla tavola dell’Eucarestia deve deporre le vesti. Le vesti del tornaconto,
del calcolo, dell’interesse personale, per assumere la nudità della comunione.
Le vesti della ricchezza, del lusso, dello spreco, della mentalità borghese,
per indossare le trasparenze della modestia, della semplicità, della
leggerezza. Le vesti del dominio, dell’arroganza, dell’egemonia, della
prevaricazione, dell’accaparramento, per ricoprirsi dei veli della debolezza e
della povertà, ben sapendo che pauper
non si oppone tanto a dives quanto a potens»[16].
L’itinerario dell’Eucarestia
giunge alla gente, ma la meta finale privilegiata sono i poveri.
Dall’accoglienza degli sfrattati in episcopio, alla raccolta concreta dei
barboni dalle strade e dalla stazione di Molfetta, la vita e gli scritti don
Tonino sono la contemplazione affettuosa ed operosa della povertà di ogni tipo,
attraverso il volto concreto che essa riveste, e che è sacramento di Cristo. Ai
sacerdoti radunati per la messa crismale raccomanda: «Miei cari fratelli,
amiamo i poveri, cerchiamoli, inseguiamoli, snidiamoli dai loro nascondigli
dove si sono nascosti per pudore, facciamone l’inventario così come facciamo
l’inventario degli oggetti preziosi nelle nostre chiese. Scusiamoli,
perdoniamoli, chiudiamo un occhio sulla loro mancanza di educazione, aiutiamoli
a crescere, con stile paziente, senza infastidirci, senza trovare scuse, forse
anche nel loro peccato, al nostro ingiustificabile disimpegno»[17].
Su questo sfondo si comprende
meglio un episodio espressivo della vita di don Tonino. A seguito di una
celebrazione svoltasi nella chiesa molfettese della Madonna dei Martiri, il
santuario riceve il titolo di «basilica minore». Ai giovani che gli chiedono di
spiegare il senso di questo titolo, don Tonino risponde che «basilica minore» è
la dimora fatta di pietra, «basilica maggiore» è invece la dimora fatta di
umanità. «Ogni uomo è basilica maggiore!», è perciò il modo in cui si conclude
la spiegazione. La stessa sera, alcuni ragazzi insieme a don Tonino trovano un
ubriaco che giace accanto all’episcopio. È Giuseppe, un uomo giovane, corroso
dall’alcol, che vive randagio per le strade della città. Alla domanda che i
ragazzi, riferendosi all’uomo riverso sul marciapede, gli rivolgono: «Basilica
maggiore o minore?», la risposta non può che essere: «Basilica maggiore!»[18].
L’arte di chiamare per nome
Nella
prospettiva biblica il nome è ciò che racchiude l’identità profonda della
persona, il mistero della sua unicità, il dono di bontà e bellezza di cui
l’uomo è portatore, il compito che gli viene affidato nella vita. In questo
senso, il segreto del nostro nome lo possiede soltanto Dio, che ce lo rivela
quando ci chiama. Nel linguaggio di Antonio Bello, tale attitudine si traduce
anzitutto nella sorprendente capacità relazionale di don Tonino. Il suo
approccio all’altro è dettato da un atteggiamento di infinito rispetto. In negativo,
ciò significa che don Tonino non parla mai male di nessuno. Se si cerca di
tirarlo dalla propria parte facendolo schierare, tace, e poi cerca di far
emergere il lato positivo della persona criticata. In positivo, si traduce nel
suo straordinario gusto di riconoscere e apprezzare il dono di ognuno. La
sua ammirevole capacità di percepire lo
specifico di ognuno lo porta a redigere le celebri liste, nelle quali, proprio
come nel brano francescano prima citato, ogni volto viene ritenuto con il
frammento di luce, di sofferenza e di bellezza di cui è portatore. Sono le
liste bibliche delle lettere indirizzate ad Abramo e alla sua discendenza, o
delle meditazioni sviluppate a partire dai piedi degli apostoli. Sono quelle
tratte dalla quotidianità contemporanea che il vescovo incontra per strada:
Antonio, il pescatore; Gennaro, l’ubriaco; Mohamed, il diverso; Maria, la pecorella
smarrita, Marta, la scheda perforata; Alfonso, il disoccupato; Marcello, il
randagio dei marciapiedi; Giuseppe, l’accattone; Luigi, oppresso dai debiti; Piero
e Alfonso, disoccupati...
Ne è condizione la purezza di
cuore, indicata dalla beatitudine evangelica. Di essa era puro il cuore di
Antonio Bello. Chiunque riceveva la possibilità di un incontro con lui, per
quanto breve fosse stato il tempo della conversazione, se ne ritraeva con una
certezza affiorata nell’anima: «Io sono la persona più importante per don
Tonino!». Naturalmente non poteva essere così, dato il numero altissimo di
persone con cui Antonio Bello entrava in contatto. Ma il suo cuore puro gli
permetteva di accostarsi ad ogni persona, dandole tutta l’attenzione possibile,
appunto facendola sentire la più importante, la più amata.
In tale solco vorrei inserire
un riferimento al suo amore per il creato.
Per limitarci ad un solo esempio, nel 1983 si trova in volo sopra
l’Oriente, diretto a far visita ai molfettesi d’Australia. Svegliato
dall’aurora, dal finestrino dell’aereo lo stupisce uno spettacolo grandioso, e
ricorre al Cantico di Frate Sole per
celebrare il Creatore: «Il sole, in un lago rosso di nuvole, o di rocce, o di
sabbie lontane, riempiva di gloria il creato. Mi è venuto d’istinto rivolgermi
all’Altissimo Onnipotente bon Signore, per indirizzargli le laude, la gloria e l’honore et onne benedizione»[19].
Il calendario segna il 4 ottobre, proprio il giorno della festa di san Francesco.
Trovandosi in aereo, la celebrazione dell’Eucaristia è materialmente impossibile.
Ma le parole della preghiera del santo di Assisi offrono a don Tonino il mezzo
per un ringraziamento altrettanto efficace e appropriato.
Il dialogo nella cortesia
Non sarebbe errato affermare
che il primo caso di dialogo interreligioso sia l’incontro di Gesù con la Samaritana (Giovanni
4,1-42). Don Tonino ha più volte dedicato a tale incontro splendidi commenti[20].
Tra i molti livelli su cui può collocarsi la lettura del brano evangelico, uno
è senz’altro quello sorprendente del fatto stesso che questo dialogo avvenga,
per due ragioni. La prima è che è un dialogo fra un uomo e una donna. I
discepoli sopravvenuti, infatti, si stupiscono che Gesù stia a parlare con la
donna, perché nella cultura del tempo la donna era ritenuta indegna di ricevere
la familiarità, l’amicizia e addirittura la parola stessa da parte dell’uomo.
La seconda ragione che rende sorprendente il dialogo è che esso si svolge fra
un ebreo ed una samaritana, cioè fra i rappresentanti di due religioni
diverse, che si scambiavano un cordiale disprezzo. La terza ragione di novità è
che il Signore rivolge la sua parola ad
una peccatrice, ad una donna che – al di là della simbologia giovannea –
viene detta passata da uomo ad uomo e tuttora convivente. Infine, la Samaritana è una meticcia, dunque diversa dal ceppo
razziale degli ebrei, in quanto appartenente ad un gruppo mescolatosi con le
etnie locali. Don Tonino nota così che, nel dialogo con la Samaritana , Gesù supera
le quattro differenze del sesso, della religione, della morale e dell’etnia. E
Gesù rende la donna protagonista di scambio, destinataria di rivelazione e
soggetto di missione.
A proposito di dialogo, ricordiamo
un evento impegnativo e profetico nella vita di Antonio Bello. Questi fa parte
dell’esercito disarmato che dal 7 al 13 dicembre 1992 parte alla volta di
Sarajevo. Nonostante il cancro che lo scava spietatamente, egli sente necessario
essere presente in questo gesto di testimonianza nonviolenta. Il vescovo di
Molfetta presenta tale progetto come in diretta continuità con Francesco che si
incontra col sultano d’Egitto. Lasciamo che sia lo stesso don Tonino a descrivere
l’accaduto.
«Nel giugno
1219, la flotta dei crociati partì da Ancona verso la Palestina , alla
conquista dei Luoghi Santi. Su una nave salì anche Francesco, col segreto
disegno di convertire i soldati a propositi di non violenza, ma anche col
desiderio di frapporsi, disarmato, tra i Saraceni e i crociati. Nel campo dei
crociati non riuscì a far desistere l’esercito dall’uso delle armi. I
combattimenti infuriarono con la forza del parossismo, e migliaia di
combattenti perdevano ogni giorno la vita. Francesco allora decise un gesto
folle: si diresse verso il campo di Melek-el-Kamel. Venne accolto con molta
simpatia ed ebbe modo di parlare non solo di Gesù Cristo, ma anche della
assurdità della guerra, che si sarebbe potuta evitare col negoziato e col
dialogo tra le due parti belligeranti. Fu ascoltato con molto interesse, ma
soprattutto fece una grande impressione questo modo inerme di presentarsi. Una
autentica rottura della logica corrente, che sconcertò positivamente il sultano
e lo Stato generale del suo esercito»[21].
Occorre notare come un tale
incontro si svolga nel segno della cortesia. La cortesia è la virtù che
anzitutto i musulmani sono tenuti a praticare nei confronti degli ebrei e dei
cristiani, come stabilisce lo stesso Corano: «Con la gente del Libro discutete sempre con la massima cortesia, salvo
con quelli che sono ingiusti» (sura 29,46). La gente detta del libro
sono appunto gli ebrei e i cristiani. Tra costoro sono ritenuti ingiusti coloro
che offendono l’islam, e con questi cessa l’obbligo della cortesia. Ebbene da
un lato il sultano accoglie Francesco con grande cortesia e ascoltandolo con
interesse. Dall’altro, se Francesco annuncia con entusiasmo e franchezza il
Vangelo, lo fa però senza insultare la fede del suo interlocutore.
L’incontro lascia una traccia sia
in Melek-el-Kamel, sia nello stesso Francesco. Appare la novità di un
approccio, che non disprezza l’interlocutore ma sa coglierne le ricchezze,
ripudia la via della violenza, e sa accontentarsi di un annuncio legato alla
semplice presenza di una confessione di fede discreta e pacifica.
Dodici secoli dopo, alla fine
dell’anno 1992, si consuma ancora uno scontro tra uomini in cui gioca un peso
importante la fede religiosa. Don Tonino interviene assieme ai suoi compagni di
testimonianza e profezia, e dichiara in modo esplicito: «Il cammino verso
Sarajevo, che partirà anch’esso da Ancona, vuole ripetere lo stesso gesto di
Francesco»[22].
Perciò egli si è trovato in
piena sintonia con lo spirito di Assisi, sorto il 27 ottobre 1986, allorché,
accogliendo l’iniziativa del papa Giovanni Paolo II, salgono ad Assisi i
rappresentanti delle chiese e delle comunità cristiane, ma anche delle
principali tradizioni religiose presenti nel mondo. In questo incontro di
preghiera, si domanda una pace che verrà donata solo come coronamento
dell’impegno per la pace da parte di tutti, e subito, già nei confini della storia.
È la pace che viene dal Padre si estende ad ognuno ed ognuna dei suoi figli e
delle sue figlie, senza distinzione di religioni.
Per l’occasione don Tonino
scrive: «Ecco il senso di questa salita ad Assisi, divenuto monte delle
beatitudini: occorre credere e sperare nella pace con amore di fratelli, oltre
che di figli. Il Padre non è disposto a parcellizzare il suo asse ereditario
seguendo i muri perimetrali delle nostre divisioni. la pace non si divide. Non
si lottizza. Non si frantuma. È come un disco la cui musica non si può far
godere da più persone rompendolo in più parti. Non c’è una pace rossa e una
pace bianca. Non c’è una pace ortodossa ed una pace musulmana. C’è una sola
pace: quella del Padre. E chi, per accaparrarsela, colloca i recipienti di
carta stagnola della sue ideologie o delle sue divisioni, compie un sacrilegio.
La pace è un valore senza frontiere. Lo ha detto più volte Giovanni Paolo II.
Anche senza frontiere religiose, naturalmente. Queste, anzi, devono essere le
prime a cadere»[23].
Assisi 27 ottobre 1986.
L’avvenimento sarà per il vescovo di Molfetta come uno dei grandi concili
ecumenici, il luogo in cui viene concepito il discorso trinitario sulla pace:
«Nicea… Costantinopoli… Efeso! Assisi… Basilea… Seoul!»[24].
Nello spirito di Assisi la scelta di dialogare tra credenti di fedi diverse non
ha per obbiettivo l’adesione dell’altro alla fede propria, ma la dilatazione
universale della pace. È un prolungamento del servizio che Gesù inaugura con la
lavanda dei piedi, e chiede alla Chiesa. Questo è anche il compito della
Chiesa: «Lavare i piedi al mondo senza chiedere come contropartita che creda in
Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi al mondo, poi lascia fare: lo Spirito di Dio
condurrà i viandanti dove vuole lui»[25].
[1] Cf. le
biografie di C. Ragaini, Don Tonino fratello vescovo, Paoline,
Milano 1994; D. Cives, Parola di uomo. Tonino Bello un vescovo per
amico, San Paolo, Cinisello B. 1995 (con particolare riferimento alla
malattia e agli ultimi giorni); R. Brucoli,
Don Tonino Bello, Messaggero, Padova
2003. Ho già approfondito altre volte la figura di don Tonino, nelle opere La gente, i poveri e Gesù Cristo, Ed
Insieme, Terlizzi 2001; Una bussola e tre
pietre bianche, Ed Insieme, Terlizzi 2003; Collocazione provvisoria, Ed Insieme, Terlizzi 2006; Il vescovo Antonio Bello, in Aa.Vv., Testimoni del Novecento, San Paolo, Cinisello B. 2006 471-494. Rimando a tali testi come fonti di quanto offro nel presente
contributo.
[2] Per tutta la
vita don Tonino manterrà un legame forte con il suo Sud: cf. A. Picicco, A Sud l’orizzonte si è schiarito. Il vescovo Tonino Bello dentro e
oltre la realtà meridionale, Ed Insieme, Terlizzi 2003.
[3] I
congressi eucaristici e il loro significato teologico e pastorale, San Paolo, Cinisello B. 2005.
[4] Sul ministero
episcopale cf. D. Marrone, Don Tonino Bello e il suo messaggio. Le
linee portanti di un magistero profetico, San Paolo, Cinisello B. 2001; A. Chiereghin, Un vescovo secondo il Concilio. Don Tonino Bello, uomo che visse
dentro, che visse insieme, che vide oltre, Ed Insieme, Terlizzi 2001.
[5] Scritti di
mons. Antonio Bello, 5 voll., Mezzina, Molfetta 1993-2003. Il sesto volume
è in fase di allestimento. Citeremo i testi di tale raccolta con la sigla AB, seguita dal numero romano del
volume, e da quello arabo delle pagine. Tale imponente raccolta, per il suo
carattere ufficiale, include soltanto i testi pubblicati durante la vita di don
Tonino. Una compilazione pressoché completa è in A.P. Camporeale, Scritti
di Mons. Antonio Bello in dieci anni di episcopato (1982-1992), in Luce & Vita Documentazione, 1993/1,
259-290. Sono utili anche le registrazioni degli interventi orali, e tra le
loro trascrizioni si possono leggere anche testi preziosi come è ad es. Cirenei della gioia, San Paolo,
Cinisello B. 1995. Infine, tranne qualche scheggia ed una piccola antologia (A.
Bello, Epistolario minimo, Ed Insieme, Terlizzi 2004), sono ancora per lo
più inedite le lettere private di don Tonino.
[6] Aspetti dello
stile del vescovo di Molfetta sono approfonditi in M. Canobbio, Tonino
Bello. Elementi per una biografia letteraria tra profezia e poesia, LAS,
Roma 1998.
[7] Non contristatevi, in Ti voglio bene, Luce & Vita,
Molfetta 1993, 59.
[8] Cirenei
della gioia, 81.
[9] I segni dei tempi (20 febbraio 1983), AB
II, 286.
[10] Cirenei
della gioia, 114s.
[11] Le tristezze dei poveri, AB III,
246s.
[12] Non contristatevi, 56.
[13] Il parcheggio del Calvario, AB II, 307.
[14] Uno per uno per uno fa sempre uno, AB II, 337. Cf. inoltre Insieme per camminare, AB I, 289-292; Giustizia, pace e salvaguardia del creato, AB IV, 160-169; La famiglia
come laboratorio di pace, AB IV,
172-183. Meritano attenzione anche la teologia del Padre, che don Tonino
sviluppa anche nell’orizzonte della «sofferenza» di Dio, commentando la Trinitas in cruce di Masaccio (cf. Un Dio che sconcerta, AB II, 394-396); e la ricca
pneumatologia, a cominciare da quella sviluppata in occasione delle messe
crismali (cf AB II, 14-98).
[15] La famiglia come laboratorio di pace, AB IV, 174-176 passim.
[16] Omelia al presbiterio regionale (23 novembre
1984), AB II, 138.
[17] Omelia per la messa crismale (1985), AB II, 36.
[18] Cf L’hai
fatto poco meno degli angeli, AB III, 192-194.
[19] Sotto la croce del Sud, AB I, 3.
[20] Cf. Al pozzo di Sichar. Appunti sulle alterità,
AB IV, 186-186-199.
[21] Verso Sarajevo, AB IV, 335s.
[22] Verso Sarajevo, AB IV, 336.
[23] Mani alzate
sul monte, AB IV, 44.
[24] Giustizia, pace e salvaguardia del creato,
AB IV, 163s.
[25] Omelia (12 aprile 1986), AB II,
145.